«Di fronte a una rivoluzione dobbiamo usare ancor di più la nostra intelligenza»
di ADRIANA VALLISARI
L’esperto: pervaderà ogni aspetto della nostra esistenza
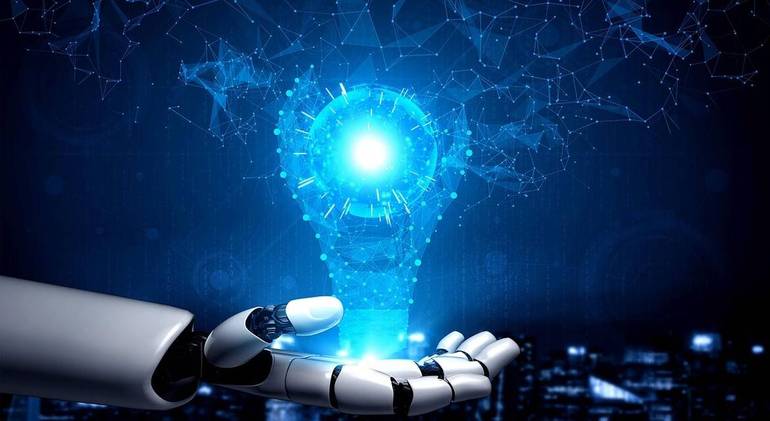
di ADRIANA VALLISARI
Prof. Andrea Tomasi, lei insegna Informatica per le discipline umanistiche al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione all’Università di Pisa ed è consigliere di WeCa (Associazione web cattolici italiani). Ci dica: siamo di fronte a una rivoluzione, come quando fu scoperta l’elettricità e cambiò il modo di vivere, di spostarsi, di relazionarsi, di lavorare?
«Possiamo parlare davvero di “cambiamento d’epoca” o di rivoluzione, perché le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale (Ai) si sono diffuse a livello globale e in così tante applicazioni che è impossibile ormai trascorrere una giornata senza averci a che fare in qualche modo, spesso senza accorgercene: perché l’Ai è inglobata in oggetti e strumenti che usiamo correntemente».
– Come si può stare in questo cambiamento senza farci prendere dall’entusiasmo o, all’opposto, dalla paura?
«La strada è quella della conoscenza. Non solo per acquisire competenze specifiche, ma soprattutto per comprendere il senso delle trasformazioni in atto e le possibili conseguenze nel prossimo futuro, soggetto a continue accelerazioni delle innovazioni tecnologiche. Occorre superare luoghi comuni (le macchine non sono “migliori” degli esseri umani) ed evitare di disperdersi in falsi problemi (le macchine non hanno coscienza, né responsabilità, né creatività)».
– L’intelligenza artificiale imita l’uomo. Impara processando grandi quantità di dati e informazioni, sa fare conteggi complicati rapidissimi, può aiutarci in campi utili alle nostre vite (per es. negli ospedali). Ma non c’è il rischio che diventi così brava da sostituire l’uomo o di piegarlo al suo servizio, in nome dell’efficienza tecnologica?
«L’Ai è come l’uomo vuole che sia. C’è il rischio che l’uomo che abbia a disposizione tale potenza, la voglia usare per un vantaggio personale a danno degli altri uomini. È il monito di Geoffrey Hinton, recente premio Nobel: “Non si può impedire a persone cattive di usare l’Ai in maniera malvagia”. L’Ai non sostituirà l’uomo, ma l’uomo dovrà vigilare perché la propria sete di potere non usi l’Ai per dominare il mondo e perché il proprio desiderio di travalicare ogni limite gli faccia accettare ogni forzatura tecnologica, come già sta avvenendo ad esempio nella manipolazione della vita umana».
– Sarà pure intelligentissima, ma l’Ai non è in grado di fare delle scelte etiche. Non sa decidere da sola cosa è buono e cosa no.
«I neuroscienziati hanno illustrato le molteplici forme di intelligenza umana, richiamate anche nel documento vaticano Antiqua et nova. Il valore da attribuire alle cose e alle azioni può essere codificato da un numero, per determinare le scelte eseguite da un algoritmo, ma quando le decisioni toccano la vita delle persone, occorre un intervento umano, perché gli esseri umani non possono essere racchiusi in un numero».
– Perché la Chiesa e papa Francesco insistono col ribadire che va tutelata la dignità umana e che la tecnologia è uno strumento a servizio dell’uomo e non contro l’uomo? Rischiamo di smarrire la nostra umanità, nell’era della tecnologia?
«La Chiesa è molto attenta all’impatto della tecnologia e al rischio della tecnocrazia. La velocità e l’ampiezza dell’innovazione tecnologica portano facilmente a concentrarsi sulla tecnologia e sul suo uso, trascurandone gli effetti trasformativi della persona umana. C’è il rischio che l’uomo perda il senso della propria umanità, di ciò che lo rende uomo, di ciò che lo qualifica come persona, riducendo se stesso a ciò che è capace di fare, esaltando la propria volontà e la propria efficienza: persa la quale, anche la vita perde significato».
– Se lo sviluppo dell’Ai potenzialmente non conosce limiti, come possiamo vigilare su di essa? Specie in un mondo in cui sono pochi i padroni degli algoritmi ed è così facile manipolare la realtà, ad esempio generando i deep fake, ovvero audio, foto e video falsi ma perfettamente credibili...
«In primo luogo, coltivando la passione per la verità, che susciti il desiderio di verificare ciò che proviene dal mondo digitale e spinga a imparare anche le tecniche per farlo. Occorre costruire una sensibilità diffusa a tale riguardo, un approccio culturale che, ne sono consapevole, appare in controtendenza rispetto al pensiero comune. Anche per questo dobbiamo parlare di emergenza educativa».
– Quali sono le ricadute sul mondo dell’educazione? Promuovere un pensiero critico nelle nuove generazioni, nate nell’era tecnologica, non è semplice...
«Le tecnologie digitali sono “ambigue”, hanno in se stesse potenzialità positive e negative, e soprattutto influenzano la cultura e la mentalità di chi vi è immerso quotidianamente, cioè in pratica di ognuno di noi. L’impegno educativo è fondamentale, ma non è facile, a maggior ragione oggi, poiché si innesta su una situazione di “emergenza educativa” che dura da anni ed è amplificata dalla cultura dei social. Proprio per questo si potrebbe iniziare educando alla consapevolezza della necessità di un “sano distacco” dal digitale. In due modi: guardando alla potenza della tecnologia senza esaltarla e senza farsene terrorizzare e imparando a farne a meno in molte attività e momenti della giornata, coltivando la vita di relazione e la spiritualità. Agli educatori il compito di offrire esempi e luoghi».
– Lei ha studiato molto Romano Guardini, teologo e filosofo di grande visione, nato a Verona nel 1885, che anticipò molte questioni che ci ritroviamo davanti ora. Cosa ci direbbe, se fosse qui oggi?
«Richiamerebbe la centralità della persona umana rispetto alla tecnologia. Offrirebbe ai legislatori un chiarimento sul modo di “governare la tecnologia”, che deve fondarsi su una visione dell’uomo e rivolgersi alla piena realizzazione dell’umanità, prima ancora di esprimersi con regolamenti a protezione di interessi economici o a prevenzione dei rischi tecnologici. E all’uomo d’oggi, condizionato dalla tecnologia, offrirebbe un orientamento educativo e spirituale: per non subire il dominio tecnocratico, occorre rafforzare la propria coscienza morale e la propria competenza culturale, senza estraniarsi dalla realtà o pretendere di sostituirsi al Creatore. Solo così potrà evitare che l’intelligenza artificiale, tecnologia potente e sofisticata, diventi strumento di dominio dell’uomo sugli altri uomini».







Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il Login per poter inviare un commento