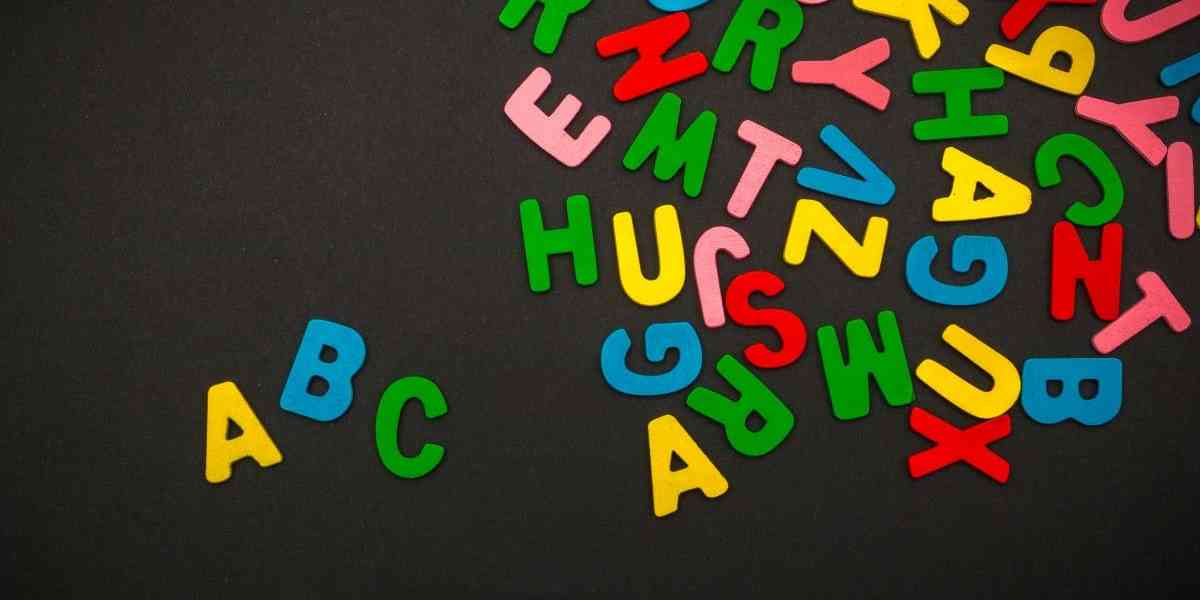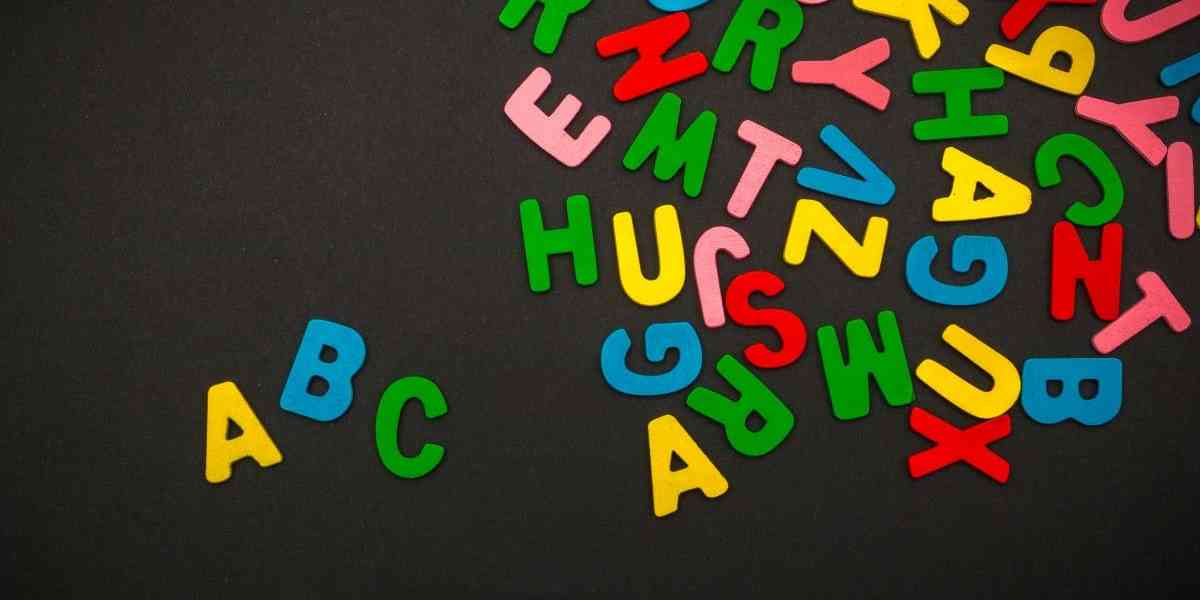Tamponare, lockdown, spillover, droplet... Quante parole nuove ha introdotto la pandemia nel nostro lessico? Tante. Alcune le dimenticheremo, altre ce le porteremo dietro per sempre. Che impatto ha avuto sulla lingua il Covid-19?
Ne parliamo con Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, che insieme a Carlo Cianetti conduce il programma Linguacce su Rai Radio1.
– A distanza di nove mesi, è cambiato il nostro modo di definire la pandemia? Se sì, come?
«Quello che si sta vedendo a livello linguistico è ciò che succede tutte le volte che accade un evento dalla portata mondiale: la realtà si sedimenta nella lingua. Dopo Chernobyl, ad esempio, tutti improvvisamente siamo diventati esperti di fissione nucleare, radioattività, contatori Geiger. È perfettamente normale, perché il nostro modo di capire la realtà è quello di nominarla. Parlandone, concettualizziamo gli avvenimenti e riusciamo a comprenderli. È accaduto lo stesso con l’attacco alle Torri gemelle o lo tsunami del 2004 nel Sud-est asiatico».
– Si sdoganano pure i tecnicismi, quindi?
«Sì, ci sono termini, prima non noti al grande pubblico, che escono dal lessico degli specialisti a volte per sempre, oppure cadono in disuso. Quando, a distanza di tempo, ci guarderemo indietro, noteremo nel 2020 un picco di lessico medico, ricorsi alla metafora bellica e tante voci legate alla salute. Anche se non sapessimo cosa successe quell’anno, dal tipo di parole ricercate su Google immagineremmo qualcosa legato alla pandemia. Il lessico incamera la realtà e fa da cartina di tornasole».
– Fin da marzo si parla appunto di Covid-19 come nemico invisibile da sconfiggere, di medici come eroi in trincea, usando un linguaggio militaresco; è normale, in tempi carichi di paure, o ci siamo fatti prendere un po’ la mano?
«La metafora bellica è la più facile da evocare, ma non è necessaria. Come ha sottolineato sul portale di Treccani il mio collega linguista Federico Faloppa, è una metafora molto dannosa, perché pone le persone in una condizione psicologica di docilità, per cui è tutto lecito. Provoca inoltre una proliferazione – senza senso – di nemici, a cominciare dai runner. Ma questa caccia all’untore non serve a niente: le cose brutte succedono, non occorre cercare un colpevole».
– Qualche colpa ce l’abbiamo anche noi giornalisti?
«Sono critica verso i mezzi di comunicazione quando usano quel tono catastrofico da “moriremo tutti”. I giornalisti hanno il privilegio di essere ascoltati, ma a volte si fanno prendere dalla fame di clic, dimenticando di essere i cani da guardia del buon senso, col compito di discernere».
– Oggettivamente, però, c’è stata molta confusione sul fronte delle fonti. Fino ad arrivare ai virologi che in tv confutano altri virologi...
«La disputa nel mondo scientifico fa parte del normale confronto. L’errore è stato pensare che fuori le persone lo sapessero, invece non è noto. Molti esperti, poi, si sono resi conto di non essere in grado di parla- re ai non esperti. Ecco, avere uno o più portavoce scientifici avrebbe aiutato».
– Come giudica invece la comunicazione di Giuseppe Conte?
«Il Governo si è trovato in una situazione nuova, va riconosciuto. Tolto questo, non mi è piaciuto il balletto dei Dpcm; in varie situazioni mi sono sentita presa in giro come cittadina, anche se ho sempre rispettato le prescrizioni. Certo, Conte paga il fatto di essere un avvocato e il lessico giuridico è pieno di arcaismi. Per vari motivi, forse talvolta non sapendo cosa dire, vi ha fatto un ricorso massiccio».
– Abbiamo imparato vocaboli nuovi, altri hanno assunto sfumature diverse (pensiamo a positivo). C’è qualche neologismo che ci porteremo appresso a lungo, secondo lei?
«Lockdown. Ci è arrivato già confezionato da Wuhan e l’italiano è una lingua molto accogliente nei confronti degli anglicismi. Lo stesso termine, cioè chiudere perché c’è una minaccia all’interno, come in una sparatoria a scuola, da noi non ha un corrispettivo: serrata nonrende, coprifuoco è più notturno. Lockdown è il nome proprio di questa situazione. Ha un retrogusto esotico, piace alla gente, che l’ha accolto anche non capendone il significato. Come quando si dà il nome a un uragano, ricorderemo il grande lockdown del 2020».
– “Andrà tutto bene”: un’espressione che rivela il nostro bisogno di aggrapparci alla speranza?
«Ha un fondo di verità: la pandemia non sarà la fine dell’umanità. Non lo trovo uno slogan stucchevole: in mezzo a una catastrofe sanitaria, la parola ci permette di narrare. Noi siamo unici perché non viviamo solo il presente, ma il passato e il futuro grazie alla parola. Personalmente, penso che andrà tutto bene, alla fine; semmai dissento dall’idea che ne usciremo necessariamente migliori».
– Qual è lo “spirito del tempo” che si respira sui social?
«C’è un po’ di tutto lì: l’incattivito, il complottista, lo spaventato, chi prende atto con stoicismo della situazione. Ciò che è cambiato con la pandemia è che ancora più persone sono confluite on line. Talvolta in modo improprio, come chi si sfoga in maniera disdicevole su Facebook. Molti pensano che i social siano di loro proprietà e in parte è vero, ma bisogna ricordarsi che sono come il balcone di casa nostra. Sul balcone ci andremmo nudi? No, allora stiamo attenti a quello che facciamo in rete».