Dalla cultura del conflitto a quella della competizione individuale
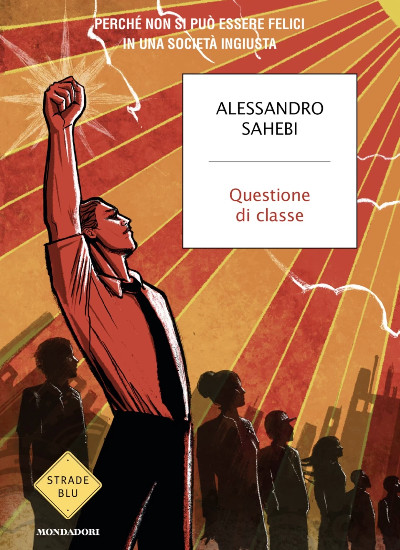
Una società basata interamente sul merito può essere felice? La risposta, immediata ed emotiva, è sì, perché il merito è quel diritto alla lode, alla ricompensa, alla stima dovuto alle capacità, alle qualità o alle azioni di una persona magari al posto giusto nel momento giusto.
Nel romanzo distopico L’avvento della meritocrazia, scritto nel 1958 da Michael Young, il sì non è proprio così scontato, giacché lo scrittore britannico vi immagina un mondo che nel 2033 vedrà regnare sovrana la meritocrazia. Questo testo è richiamato in Oltre la meritocrazia, uno dei 6 capitoli che compongono Questione di classe di Alessandro Sahebi. L’autore attacca le narrazioni dominanti nella nostra società – non solo il mito della meritocrazia, ma pure l’ossessione per il risultato, l’equazione tra fallimento economico e colpa individuale, l’ignoranza, vista soprattutto a sinistra, come “la risposta facile a fenomeni complessi” – per offrire un ritratto, anche crudo, di un secolo che ha cambiato il mondo. Se in quello del Novecento esistevano una cultura della solidarietà e del conflitto in tutti gli ambiti (familiare, scolastico, lavorativo), nell’attuale il conflitto è stato sostituito dalla competizione individuale e, in tale contesto, “ammettere un problema equivale a dichiarare una debolezza che deve essere nascosta. Il vero dramma, oggi, è quindi l’assenza di questo conflitto. Il dolore individuale resta confinato, non trova un rispecchiamento nella collettività, non si traduce in una lotta condivisa. La sofferenza viene atomizzata, privata del suo potenziale di trasformazione sociale. Così, anziché alimentare un senso di solidarietà e di appartenenza, genera frammentazione e isolamento. È un vuoto politico e umano, dove… non funzionerà mai del tutto andare dallo psicologo per risolvere i conflitti con il capo o con i colleghi”, scrive Sahebi. Perché nell’attuale società è quanto hai e quanto produci ciò che ci definisce, non gli ideali, le passioni oppure le relazioni interpersonali.
L’essere quindi ben forniti e ben vestiti tende a determinare la nostra felicità o la nostra tristezza. Ma qualcosa, per l’autore, sta lentamente cambiando: sempre più donne e uomini rifiutano l’identificazione totale con la carriera, con il rendimento sul lavoro come principale misura di quel che si vale, con la privazione dei propri spazi e dei propri tempi barattati per un aumento di stipendio. Nell’attuale società, ben lontana dall’essere equa, felice e giusta, riecheggia quanto affermato da Young: “Se non si può giocare altro che un calcio di prima fascia, che cosa si deve fare di tutti quelli che non sono abbastanza bravi per essere ammessi nella squadra?”. Domanda che continua a non avere risposta, oggi come nel 2033, e che resta irrisolta anche nel saggio – benché lucido, provocatorio e rigoroso – di Sahebi.
Tutti i diritti riservati
Sei un abbonato a Verona fedele e desideri consultare il giornale anche via web, sul tuo computer, su tablet o smartphone?
Lo puoi fare in modo rapido e gratuito. Ecco alcuni semplici passaggi per accedere alla tua edizione online e per installare l'App:
Lo puoi fare in modo rapido e gratuito. Ecco alcuni semplici passaggi per accedere alla tua edizione online e per installare l'App:





